 «Ancora nessuna notizia del piccolo Tommaso. Un silenzio che fa paura».
«Ancora nessuna notizia del piccolo Tommaso. Un silenzio che fa paura».
“Povero piccolo, chissà la famiglia cosa starà vivendo in questo momento” pensò l’uomo sulla sessantina dopo aver letto uno dei vari titoli che apriva la quasi totalità dei quotidiani nazionali.
Tommaso Viri, 4 anni, figlio di Luca Viri e Marisa Talli, era stato rapito tre giorni prima nel giardino della sua scuola materna. Le videocamere di sorveglianza avevano immortalato l’arrivo di tre uomini incappucciati che, dopo aver bloccato le due insegnanti presenti al momento, prelevavano il piccolo individuandolo facilmente tra gli altri, scomparendo poi a bordo di un’auto, ripresa solo in minima parte. Un prelievo mirato.
Il padre, Luca Viri, era l’ex proprietario dell’industria di materiali plastici Viriplast che, per oltre quarant’anni, aveva garantito linfa vitale al piccolo paese in cui era collocata.
Dopo aver preso le redini dell’azienda alla morte del padre, il fondatore Tommaso Viri, e a seguito di una crisi del settore che stava coinvolgendo anche la sua impresa, Luca aveva pensato bene di delocalizzarla in Portogallo, così da risollevarne le sorti economiche, per poi cederla, breve tempo dopo, per sei milioni di euro, ad un industriale lusitano.
Di fatto, Luca Viri aveva decretato la morte economica dell’intera popolazione del suo paese, tutta connessa, o quasi, alla fabbrica e al suo indotto. Immediatamente dopo la sua decisione, ne era nata una violenta crisi locale, con chiusure di negozi e gravi problemi per gli ex lavoratori che, nella quasi totalità, si ritrovavano praticamente estromessi dal mondo del lavoro grazie anche alla politica di uno Stato che ti offre apprendistati sino ai ventinove anni per poi ritenerti vecchio dai trenta in su, col benestare dei sindacati, oltre a prevedere, ad ogni cambio di governo che, ormai, andava di pari passo con il periodo di rivoluzione siderale di Mercurio, un piano economico per il Sud il quale, puntualmente, veniva disatteso per i motivi più disparati.
E tra le varie soluzioni adottate per reagire al colpo della chiusura della fabbrica, tra piccoli lavori in nero e tentativi falliti di emigrazione, era sorta, in alcuni casi, anche la più drastica: il suicidio.
E la Viriplast, al netto di tutto ciò, era stata una sorta di oasi nel deserto in quella parte del subappennino pugliese che arrancava ormai da decenni, trascinata solo dall’industria agraria, sempre più sull’orlo del baratro, ed era vessata dalla piaga dell’emigrazione giovanile che aveva fisicamente svuotato gran parte dei centri abitati.
«Maresciallo, ci sono novità su mio figlio?».
«No, mi spiace».
Dopo quattro giorni dalla sparizione, Luca Viri, come ogni mattina, si recò presso la Caserma dei Carabinieri per chiedere novità sulle indagini.
I carabinieri stavano tentando qualcosa per venirne a capo, poca roba in realtà, e, ad ogni minuto trascorso lontano dal piccolo Tommaso, l’ansia e la paura prendevano sempre più possesso degli stati d’animo dei coniugi Viri.
«Scusi se glielo chiedo nuovamente, ma lei è certo di non immaginare chi possa avercela con la sua famiglia?» domandò con voce pacata il maresciallo, seduto dietro la sua scrivania, carezzandosi i baffetti sottili, quasi una stretta linea nera che seguiva la curva delle labbra e dava colore ad un viso piuttosto chiaro.
«Come le ho già detto, non direttamente. Posso solo ipotizzare che c’entri qualcosa con la chiusura dell’azienda» rispose affaticato Viri, con gli evidenti segni della stanchezza sul volto che ne avevano devastato, in pochi giorni, i lineamenti curati.
«Nessun debito, nessun conto in sospeso?».
«No».
Il maresciallo Cecchini fissò l’uomo in cerca di qualcosa che, al momento, sfuggiva alla sua attenzione.
Fu lo squillo del cellulare di Viri ad infrangere quel silenzio che ristagnava in quella stanza da un paio di minuti.
«Tesoro, che succede?».
Dall’altra parte del telefono Marisa Talli, sua moglie, in evidente stato confusionale, balbettava frenetica parole prive di senso.
«Stai calma e respira» disse l’uomo autocontrollando la propria tensione.
La donna ripeté qualcosa di incomprensibile, poi si fermò.
«Respira profondamente, non parlare» continuò il marito.
Lei, a fatica, seguì il consiglio. Tre-quattro respiri profondi, poi riprese a comunicare e fu più chiara.
«Arrivo subito».
«Che succede?» chiese il maresciallo.
«Mia moglie, è terrorizzata. Dice che è arrivato qualcosa a casa che riguarda Tommaso. Una lettera, credo».
«Andiamo insieme».
Pochi minuti dopo, i due raggiungevano la villa dei Viri posta poco fuori il centro abitato. Ad attenderli Marisa.
La donna, quasi una riproposizione al femminile della “rovina” fisica del marito, seduta sul divano, tremava vistosamente. Stretta nella mano destra un foglio che, alla vista di Luca, allungò verso di lui accentuando il proprio tremolio.
L’uomo lo afferrò e lo lesse più volte. Poi, meccanicamente, lo porse al maresciallo.
«Il bambino sta bene ma la sua salute dipende solo da te e ti costerà tre milioni di euro. Domani sera, ore 23.30, piazzola antistante il lago, tra la prima e la seconda panchina. Tommaso sarà lì. Vieni da solo o… immagina un possibile scenario…» lesse con un filo di voce il carabiniere.
«Che facciamo?» domandò confuso Luca Viri.
«Non pagherete, questo è certo».
«Ma è in gioco la vita di nostro figlio».
«Lo so. Domani sera lei andrà all’appuntamento, ma ci saremo anche noi».
«E non sarà pericoloso?».
«Faremo in modo che non lo sia».
«Ma perché abbiamo deciso di fare lo scambio di notte e al lago?».
«Perché è uno scambio che non faremo».
«In che senso?» chiese confuso uno dei quattro rapitori.
«Lo mettiamo solo alla prova. Se viene con i carabinieri, allora decideremo se dargli una seconda opportunità. O un cadavere».
Intanto, in una stanza attigua, seduto su una sedia, con mani e caviglie legate, bavaglio sul viso, il piccolo Tommaso piangeva silenzioso.
«Ho i soldi. Dov’è mio figlio?».
«Scusa?» domandò sorpreso un ragazzo sui venticinque anni abbassando il finestrino della sua auto, dopo esser stato interrotto dal bussare improvviso sul vetro. Accanto a lui, nell’auto, una ragazza.
«Dov’è Tommaso?» proseguì Luca.
«Ma che diavolo vai blaterando?».
«Scenda dall’auto con le mani ben in vista» intimò il maresciallo Cecchini che era comparso d’un tratto, insieme ad altri tre carabinieri, alle spalle dell’uomo.
Il ragazzo, preso alla sprovvista, eseguì e, aperto lo sportello della macchina, guadagnò l’esterno.
«Scenda anche lei» ordinò poi alla ragazza.
Lei eseguì spaventata.
«Che diavolo succede?» domandò il ragazzo.
«Perché siete qui?» domandò il maresciallo.
«E glielo devo spiegare?» disse ammiccando, nonostante la situazione, il giovane.
«Credo si siano presi gioco di noi» ammise mestamente Luca Viri crollando su una delle panchine.
«Come mai siete proprio in questo punto e a quest’ora?» proseguì Cecchini.
«È reato desiderare dell’intimità con la propria fidanzata in questo punto e a quest’ora?» domandò quasi strafottente il ragazzo.
Il maresciallo lo fissò collerico, infastidito dall’arroganza del giovane.
«Date un’occhiata all’auto» ordinò poi ai suoi uomini.
«Può farlo? E cosa sta cercando? Non siamo drogati».
«Stai zitto» intimò categorico Cecchini.
Il ragazzo serrò la lingua, osservando le operazioni dei gendarmi che, dopo aver controllato l’interno della vettura e il bagagliaio, si accingevano a perlustrare la zona limitrofa senza risultati.
«Come ti chiami?».
«Stefano Poliseno».
«Prendi la tua ragazza e vattene a casa, Stefano».
«Come immaginavo».
«Ottima idea la tua, Stefano».
«Come quella di rapire il mocciosetto».
La mattina seguente, Stefano Poliseno raggiungeva gli altri tre membri della banda presso la fattoria semi-abbandonata di Arturo, luogo di prigionia del piccolo Tommaso situato nelle campagne che, ironia della sorte, distavano all’incirca cinquecento metri in linea d’aria dalla villa dei suoi genitori.
La sua idea, semplice, fu eseguita alla perfezione. Recarsi sul luogo dell’appuntamento con Luca Viri in “incognito”, in compagnia della propria fidanzata, ignara di tutto, e verificare la malafede del genitore di Tommaso, vista l’impossibilità tecnica di reperire il denaro del riscatto, tre milioni di euro, in così poco tempo.
«Ed ora?» domandò il padrone di casa.
«Ed ora dobbiamo riflettere bene sul prosieguo. Altra chance per la famiglia del bambino o fine delle danze?».
I quattro scambiarono occhiate interrogative.
«E tu credevi che non avrebbe chiesto aiuto ai Carabinieri?» chiese d’un tratto uno dei due silenziosi spettatori, Michele.
«Certo che no. Altro punto a suo sfavore» rispose secco Stefano.
«Comunque, pensate davvero valga la pena tirare ancora la corda e pensare addirittura di uccidere quella creatura?» proseguì l’altro, la cui fiducia nell’operazione iniziava a scricchiolare.
«Pensa a tuo padre e traine le conseguenze».
«Papà, dove sei?».
Quel pomeriggio Michele era rientrato a casa più tardi del solito, dopo aver trascorso delle ore con Arturo alla ricerca di un lavoro su internet, condito dall’invio di decine di curriculum consapevole che solo una piccolissima percentuale di quelle mail avrebbe trovato, dall’altra parte, qualcuno intenzionato a sprecare un paio di minuti per leggerle e, nell’eventualità, rispondere con il più classico del “Le faremo sapere” o “Al momento il nostro organico è al completo. Inseriremo il suo nominativo nel nostro database per eventuali future opportunità lavorative”.
Sua madre era scomparsa quattro anni prima a causa di un tumore feroce che l’aveva consumata nel giro di dieci mesi.
«Papà, sei uscito?» proseguì, spostandosi tra i vari ambienti dell’abitazione.
Sì, era uscito. Dal mondo dei vivi.
Lo trovò penzolante in cantina. Legata ad uno dei ganci che in passato era servito alla stagionatura della carne suina, e stretta al collo dell’uomo, una cinghia in pelle aveva già svolto perfettamente il suo compito.
Michele, figlio unico, fu investito da un treno in corsa. Svenne e restò incosciente per un tempo indefinito. Poi, ridestatosi, si ritrovò nuovamente faccia a faccia con la realtà. Suo padre aveva deciso di farla finita.
Si mosse a scatti all’interno dell’ambiente umido. Cercò di “sganciare” il corpo morto del genitore ma le forze vennero meno ben presto. Poi si buttò a terra. E pianse.
Con gli occhi offuscati dalle lacrime si guardò intorno, urtando con lo sguardo un foglio collocato sul piano da lavoro.
Si alzò, asciugò il viso e lo afferrò. Era una lettera.
Figlio mio,
scusami per ciò che ti sto lasciando: il mio corpo morto.
Non ce la faccio più. Prima tua madre, poi il lavoro: le mie uniche certezze. Non ho più retto.
Nessun futuro davanti a me, solo un baratro. Ho dato l’anima per assicurare a te e a Matilde una vita non dico perfetta, ma almeno dignitosa, ma il destino, o Dio, ha voluto mettermi alla prova. E ha vinto.
Sono un debole, lo so.
Non odiarmi
Ti voglio bene
La rilesse, bagnandola con le lacrime che scendevano copiose.
Poi trovò il coraggio di chiamare i Carabinieri.
E, intanto, quell’immagine, tatuata nel suo cervello, ogni notte, da oltre quattro mesi, come un loop malefico prendeva forma nella sua mente costringendolo a ridestarsi più volte nel cuore dell’oscurità.
Ed ora Michele, con Arturo, Stefano e Pietro, era uno dei quattro rapitori del piccolo Tommaso.
«Maresciallo, buongiorno. Sono Luca Viri. È arrivata un’altra lettera. La prego, venga subito».
Dopo un giorno di “trattative”, i quattro avevano deciso di concedere una seconda, ed ultima, opportunità alla famiglia Viri. Ed ora, la nuova richiesta, era tra le mani dell’uomo.
«Un vero peccato aver trovato il nostro punto di incontro occupato. Ma noi eravamo comunque lì, ad osservarti. E abbiamo visto. Un altro errore del genere e, a malincuore, dovremo dire addio ai rispettivi obiettivi. Probabilmente la tua sconfitta sarà maggiore della nostra. Ci vediamo domani sera, stesso posto, stessa ora» lesse il maresciallo, lasciando percepire nitidamente la sua preoccupazione nel tono della voce.
«Devo chiamare la banca. Subito» dichiarò il padre di Tommaso appena il carabiniere terminò la lettura.
«Aspetti. Fermo restando che sarà impossibile ottenere dalla banca quei soldi in poco tempo, io rappresento comunque la legge e non posso permetterglielo» rispose Cecchini, cercando di far percepire tutta la sua autorità.
«E allora? Aspettiamo che ammazzino mio figlio?».
«No, dobbiamo prendere tempo e proseguire con le indagini».
Luca Viri lo fissò con un misto di rabbia e paura.
«Lo troveremo» aggiunse poi poco convinto il maresciallo.
Mancavano un paio d’ore all’appuntamento. I Carabinieri avevano trascorso l’intera giornata, e il pomeriggio precedente, nella vana ricerca di indizi, ispezionando e interrogando, giungendo al classico nulla di fatto.
Amareggiato, il maresciallo Cecchini aveva comunicato a Luca Viri l’infruttuosità delle ricerche, invitandolo a recarsi all’appuntamento. I Carabinieri sarebbero stati presenti, ma con effetto sorpresa. Non aggiunse altro.
Nella piazza principale del paese, situata in uno dei punti più alti dell’abitato posto su una modesta collina, ai piedi del monte che ospitava anche il lago, il solo locale ancora aperto al pubblico era il Bar Tanino. Sorto durante il “boom economico”, era ormai tra le poche attività che ancora avanzano stoiche nella tormenta causata dalla chiusura della Viriplast.
Seduto ad uno dei tavolini all’aperto del bar, dalle prime ore del pomeriggio, Stefano.
Tra una chiacchiera e l’altra con i pochi avventori del caffè e con il proprietario, una birra e qualche sigaretta, il ragazzo non distraeva mai lo sguardo dalla strada che, a pochi metri di distanza dalla sua posizione, biforcandosi, correva ripida verso il bacino lacustre.
Erano da poco passate le diciannove quando una camionetta, con a bordo quattro carabinieri, passò davanti alla sua postazione lasciando il paese.
Un sorriso beffardo apparve per qualche istante sul suo volto. Poi, alzatosi, si spostò di qualche metro dal tavolo e, recuperato il cellulare dalla tasca, scorse tra le ultime chiamate effettuate rintracciando la voce “Arturo” e lasciò partire la telefonata.
«Visto nulla?».
«No».
«Come previsto, perfetto».
«Che faccio?».
«Resta lì. Ti chiamo io» e interruppe la chiamata.
Riprese il posto al tavolo e, dopo aver fatto un cenno verso il cameriere, ordinò qualcosa da mangiare. Sarebbe rimasto lì sino alla visione dell’auto di Luca Viri.
«Non ci ha lasciato altra scelta. Peccato per il bottino».
Erano da poco trascorse le 23.30 e, dopo aver osservato compiaciuto il passaggio di una seconda auto dei Carabinieri intorno alle 22 e, alle 23.15, quella di Viri, Stefano aveva richiamato Arturo comunicando la fine della “missione”.
Quest’ultimo aveva trascorso parte della giornata nei pressi del Campo Sportivo locale, collocato poco oltre la diramazione che ascendeva verso il lago o proseguiva verso il centro abitato limitrofo, con il compito di controllare se le auto con a bordo i gendarmi avessero preso una direzione diversa.
Ora, i quattro si ritrovavano nella fattoria con il compito di chiudere il sipario sulla questione.
«Che si fa, allora?» domandò Michele che, nonostante tutto, era sempre propenso a non ricorrere all’extrema ratio.
«Non c’è altro da fare. Un sacrificio per le innumerevoli vittime che quel bastardo ha provocato» sentenziò crudo Stefano.
Nell’ambiente calò un freddo silenzio che fu rotto qualche secondo dopo dalla semplice domanda di Pietro: «Chi lo farà?».
«Uno di noi» rispose Stefano.
«Sì, ma chi?».
I quattro si guardarono l’un l’altro cercando di capire chi si sarebbe immolato per la causa.
«Sorteggio» propose Stefano.
«Sorteggio?» domandò un po’ disorientato Arturo.
«Vuoi farlo tu? O c’è un volontario?».
«No».
«E allora lo sorteggeremo» e, così dicendo, Stefano si spostò verso il vecchio camino posizionato al centro della parete occidentale della stanza.
Sul basamento in mattoni rossi che rialzava da terra il focolare, quest’ultimo emanava ancora l’odore pungente della fuliggine che lo foderava completamente al suo interno, accanto all’attizzatoio, vi era una vecchia scatola di fiammiferi ammaccata. L’aprì, estrasse quattro cerini, ne spezzò uno a metà e tornò dagli altri ragazzi.
«Quattro fiammiferi, ad ognuno il suo. Chi pesca quello corto ammazza il bambino. Io terrò l’ultimo. Forza, inizia tu» e porse la mano chiusa, che occultava le porzioni inferiori dei cerini, sotto il naso di Arturo.
Quest’ultimo li scrutò attentamente, poi ne afferrò uno, lo estrasse lentamente e, alla vista della sua interezza, un sospiro di sollievo nacque spontaneamente.
«Vai» disse poi Stefano a Pietro.
Anche lui ripeté l’azione soppesando la scelta e l’estrazione, con molta calma, e, anche lui, fu fortunato.
«Siamo rimasti io e te, Michele. Procedi».
Michele avvicinò piano la sua mano a quella dell’altro. Tremava. Osservò quelle due minuscole teste rossastre cercando di intuirne quale fosse monca. Poi, chiuse gli occhi, ne prese uno e tirò via.
Era corto.
«Toccherà a te» sentenziò glaciale Stefano mostrando l’ultimo fiammifero integro.
Michele sbiancò.
«M-ma… c-come… c-ome f-faccio…» balbettò confuso.
«Colpo secco. È un bambino».
«N-non voglio vedere il suo s-sangue».
Gli altri si fermarono a riflettere per corrergli in soccorso.
«Il pozzo» disse d’un tratto Arturo.
«L-lo affoghiamo?» domandò Michele.
«No, il pozzo è secco ma è profondo almeno venti metri, se non più. Buttalo laggiù legato. Se non muore sul colpo, allora morirà di fame e sete».
Il carnefice nato dalla sorte pesò incredulo quelle parole pronunciate con così tanta naturalezza dall’amico da restarne inorridito. Ma, ormai, col trascorrere dei secondi, diveniva sempre più cosciente che, in quella situazione, vi si era cacciato volontariamente. Ed ora non aveva altra scelta che andare sino in fondo.
E poi, nella sua mente, apparve suo padre, il suo corpo penzolava dal soffitto privo di vita. Senza dire altro, ed evitando di guardare oltre gli altri tre, Michele raggiunse Tommaso nella sua prigione.
Il piccolo era lì, mani e caviglie legate, bavaglio sul volto. Inerme. Quando lo vide entrare iniziò a piagnucolare.
Michele si fermò ad osservarlo, pochi attimi. Non voleva dare il via ai ripensamenti. Poi gli si avvicinò e, sollevato di peso quei poco più di quindici chili di pelle ed ossa, guadagnò l’esterno.
Il pozzo era situato a meno di cinque metri dalla struttura abitativa, sulla destra. Una volta lì, poggiò il bimbo sulla nuda terra, scostò il tavolato in parte marcio che copriva la vera e diede un’occhiata al suo interno.
Il chiarore lunare lasciava intravedere solo una piccola striscia della porzione più alta di quel profondo budello. Più giù buio totale.
Michele alzò gli occhi al cielo, mormorò qualcosa di incomprensibile e fece il segno della croce.
Infine, portò la sua attenzione nuovamente su Tommaso. Lo afferrò e, meccanicamente, lo sospese sull’oblio.
Il bambino era scosso da fremiti violenti di terrore e cercava di urlare nonostante la striscia di stoffa fosse ben stretta alla bocca.
Il suo esecutore distolse lo sguardo dalla sua figura. Poi, improvvisamente, lasciò la presa.
Oltre venti metri di volo nel vuoto, un tonfo sordo e nessun lamento.
Come un automa, Michele riposizionò il tavolato sull’apertura del pozzo, si portò verso la sua auto, salì a bordo e s’allontanò.
Raggiunta la propria abitazione, aprì la porta, lasciandola spalancata e con la chiavi nella serratura, ed entrò. Si mosse a passo sicuro, con le luci spente, verso la cucina, scostò il tappeto posto esattamente al centro della stanza e sollevò la botola che dava accesso alla cantina.
Azionò l’interruttore della luce e discese i nove gradini dello stretto e basso passaggio chinando la testa. Una volta all’interno dell’ambiente umido, sfilò la cinghia dei pantaloni, prese una sedia, collocandola esattamente al di sotto del gancio che aveva sorretto il corpo paterno sino a togliergli la vita, e vi salì sopra.
Con molta cura assicurò la cintura all’occhiello, avvinghiandola poi intorno al proprio collo.
Un calcio alla sedia e, in breve tempo, poté riabbracciare i suoi genitori.
(pubblicato nell’antologia “Phantom Punch” – SensoInverso Edizioni, 2021)







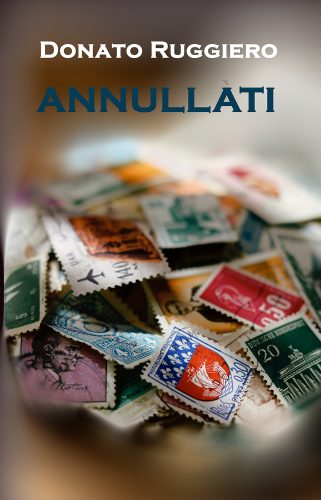

Lascia un commento