 Un caro benvenuto al tastierista e compositore Michele Conta.
Un caro benvenuto al tastierista e compositore Michele Conta.
Iniziamo la nostra chiacchierata dalle origini. Quali sono i tuoi primissimi passi nel mondo della musica e i primi “amori”?
M.C.: Da bambino mi piacevano le trasmissioni televisive dove c’era la musica leggera italiana… cercavo di ricantarle dopo averle registrate col registratore a bobina degli anni ’60 (il mitico Gelosino). Un giorno mio padre mi portò nell’unico negozio di musica della mia città, mi comprò una chitarra acustica e mi iscrisse all’Istituto Civico di Musica di Asti. Al terzo anno di teoria solfeggio, quando dovevamo scegliere lo strumento musicale, non ebbi dubbi sul pianoforte!
Quindi andando spedito con gli studi, mi iscrissi al conservatorio di Alessandria per continuare a studiare il pianoforte. Intanto all’età di 16 anni, durante una manifestazione nella mia città, rimasi letteralmente sbalordito da una band che faceva cover di rhythm and blues e rock: era la Locanda delle Fate.
Il caso, o il destino, ci mise del suo. Infatti, mio padre lavorava nella stessa azienda di Luciano Boero (il bassista) e così, parlando spesso tra di loro di musica, venne a sapere che nella band erano rimasti in tre e cercavano un pianista, un chitarrista e un cantante. Subito non ero molto convinto perché non volevo contaminare i miei studi, poi, alla fine, dopo qualche mese, si decise per una serata a casa mia dove, con grande timore, mi esibii davanti a Giorgio, Oscar e Luciano. Alla fine della serata mi ricordo i commenti che più o meno dicevano: molta tecnica, impronta classica, però vale la pena tentare un innesto con noi.
Nello stesso periodo si aggiunse anche Alberto Gaviglio (cantante, flautista) ed Ezio Vevey (chitarrista). E così iniziammo a provare cover di gruppi Rock Progressive inglesi (ad esempio Yes, Gentle Giant, Genesis, ecc.) e io, man mano che passavano i mesi, acquistavo sempre di più dimestichezza con i giri armonici del rock, e quindi con un nuovo modo di suonare il pianoforte, e con l’uso delle tastiere elettroniche.
Ci indebitammo parecchio con la nuova strumentazione e quindi cominciammo ad accettare ovunque ci facessero suonare e, negli anni ‘70, non era difficile perché nelle feste dei paesi o nelle discoteche era normale dedicare un paio di ore all’ascolto di una band senza ballare. Quando anche l’ultima rata fu pagata, io ed Ezio fummo categorici: adesso dobbiamo metterci a fare musica nostra… Quindi ci chiudemmo letteralmente nella nostra cantina per circa un anno. In quel periodo scoprii la mia vena compositiva, per cui, per fartela breve, riuscì a partorire quattro dei sette brani che andarono a comporre l’album “Forse le lucciole non si amano più”.
E, d’un tratto, appunto, nella tua vita arriva la Locanda delle Fate. Ma, prima di loro, hai avuto qualche altra esperienza in band locali?
M.C.: Qui devo fare un passo indietro perché io avevo già conosciuto Ezio un paio di anni prima, all’età di 15 anni. Lo avevo sentito suonare con una band scalcinata su un palchetto del sobborgo chiamato Valgera ed entrammo subito in sintonia. Così convinsi mio padre, il sabato pomeriggio, a portarmi a casa di sua nonna in campagna per dar sfogo a tutto volume alle nostre idee.
Ricordo bene le lamentele dei contadini delle cascine vicine che dicevano a sua nonna che le mucche nelle stalle erano nervose a causa nel volume troppo forte della musica. Quindi quando ci ritrovammo nella Locanda questo facilitò molto l’amalgama della band.
Come hai ricordato, la Locanda delle Fate nasce poco prima della metà degli anni ’70 come cover band. Come cambia, dunque, l’“essenza” della band con il tuo ingresso in formazione?
M.C.: A questo punto per merito di tutte le esperienze da me fatte fino ad allora: il conservatorio, il periodo delle cover, l’ascolto dei gruppi inglesi, ecc. Scoprii che facilmente riuscivo a trovare mie idee fino a costruire col piano un intero brano Progressive e devo dire che, per nessuno dei quattro brani che sono stati accettati, è stata cambiata una virgola della struttura musicale. In pratica, io partivo col piano, facevo ascoltare tutto il brano per intero e nulla veniva cambiato nella sequenza delle varie parti ritmiche e melodiche. Da qui iniziava poi l’inserimento dei vari strumenti che letteralmente si incastravano con le varie parti del piano. Questo inevitabilmente ha portato il piano a dare un’impronta importante ai brani poiché ne costituiva la trama su cui venivano inseriti tutti gli altri strumenti. Avere il piano come struttura portante ci ha facilitato anche in sala di registrazione a Milano perché si partiva a registrare in sincrono piano e batteria e successivamente venivano addizionati gli altri strumenti.
Dopo aver registrato professionalmente i brani su nastro da proporre alle case discografiche, il vostro materiale viene ascoltato da Giorgio Calabrese, autore e conduttore Rai di un programma dedicato alla scoperta di nuovi talenti. Siete così invitati a Roma dove, in tre giorni, registrate mezz’ora di concerto live, poi trasmesso nel gennaio 1976. Che ricordi hai di quell’esperienza?
M.C.: Lo speciale RAI dedicato alla Locanda delle Fate fu innanzitutto l’occasione per passare da band di provincia all’attenzione nazionale e poi diede la spinta finale per la firma del contratto con la Polydor, nel senso che Niko Papathanassiou si era già impegnato nel produrre il nostro disco, e questa trasmissione convinse i vertici della Polygram ad accelerare la firma, forse nel timore che altre case discografiche si facessero avanti.
Ti racconto alcuni aneddoti tratti da quell’esperienza. Uno personale: la sera prima di iniziare le registrazioni, andammo a cenare in una tipica trattoria romana e io fui messo KO da due bicchieri di vino bianco dei Castelli, per cui passai la notte in bianco in albergo con il conforto di Ezio, che condivideva con me la camera. Ma a vent’anni questi “effetti collaterali”, per fortuna, passano in poche ore e il giorno dopo ero perfettamente in forma per suonare.
Il secondo ricordo è lo stupore dei tecnici audio della RAI nel vedere le capacità di Giorgio e Oscar nell’organizzare le registrazioni, dalla microfonazione degli strumenti alla taratura dei nostri amplificatori e delle apparecchiature elettroniche che erano molto più all’avanguardia di quelle degli studi RAI. Insomma, si capiva benissimo che stavano imparando qualcosa da noi.
Poi, durante le registrazioni, ci fu qualche disaccordo nell’impostazione del programma, nella scelta dei brani, nei livelli sonori, ecc., perché comunque noi volevamo dare una certa immagine. Per questo, alla fine della registrazione, non ci aspettavamo i complimenti dalla regista Fernanda Turvani e di Giorgio Calabrese che ci raccomandarono di continuare a tenere alta la qualità della musica e non scendere a compromessi commerciali.
Il 1977 è l’anno del vostro esordio discografico “Forse le lucciole non si amano più”, uno dei dischi più apprezzati del periodo giunto, però, “fuori tempo massimo”. I brani del disco li avete composti in una formazione a sei e, solo dopo, Leonardo Sasso, con il suo timbro vocale inconfondibile, è giunto nella squadra. Chi era la persona destinata allo “strumento vocale” prima del suo arrivo? E, a proposito, come entrate in contatto con Leonardo?
M.C.: Ritornando un po’ indietro nella mia storia mi chiedi dell’incontro con il cantante Leonardo Sasso… Eravamo ormai verso la fine della parte compositiva, sia degli arrangiamenti che dei testi, e sentivamo la mancanza di una voce che desse un’identità vocale alla band. Durante il periodo “cover” il compito di cantare era di Alberto (ex cantante e chitarrista della band La polvere nera), sicuramente il più dotato fra noi.
L’incontro con Leo avvenne un po’ casualmente, nel senso che Luciano ci parlava di questo personaggio conosciuto ad Alba con una voce molto personale e potente, e anche molto esuberante (tra l’altro aveva attirato la sua attenzione poiché si era lanciato con la bici dal trampolino della piscina comunale). Lo conoscemmo. Leonardo ci raccontò la sua storia di ragazzo romano con una famiglia di artisti, padre attore e mamma pianista; aveva militato nel gruppo delle Esperienze, primo nucleo del Banco del Mutuo Soccorso, ed era grande amico di Francesco Di Giacomo.
Le prime volte che venne alle prove si limitò ad ascoltare la musica ed assimilare i testi e poi ci fu la sera in cui fece la sua prima prova con noi. Fummo davvero colpiti da come i brani acquistassero un suono particolare con la sua interpretazione e la voce possente… ci eravamo accorti che lui si era veramente impadronito dei testi… Alla fine nessuno di noi aveva dubbi: Leonardo era il settimo elemento che ci mancava.
E poi i brani, come hai anticipato, arrivano all’orecchio anche di Niko Papathanassiou, fratello di Evanghelo Papathanassiou, in arte Vangelis, il quale decide di produrre personalmente il disco (che esce per la Polydor). Conti alla mano, però, tra la prime registrazioni dei brani e la sua uscita ufficiale, trascorrono più o meno due anni. Pensi che sia stato solo questo eccessivo ritardo nella sua uscita ufficiale, al netto della “flessione” che già a metà decennio aveva colpito il genere, a decretarne il poco successo? O “l’orecchio” del pubblico era già rivolto altrove?
M.C.: Hai ragione, spesso ci sentiamo dire che il disco è arrivato fuori tempo massimo, nel senso che il Progressive era già giunto al culmine della propria creatività contaminando il rock con i generi più diversi: il jazz, il folk, la musica classica…
Sicuramente il periodo delle cover ci ha fatto perdere un po’ di anni preziosi. D’altra parte, si potesse riscrivere due volte la storia, magari…
Posso dirti che noi eravamo sinceri quando l’abbiamo composto ed era quello che ci sentivamo di dire in musica e parole per rappresentare i sogni e le delusioni dei ragazzi di quella generazione. La sincerità e l’immediatezza della scrittura e forse parte del segreto per cui l’album viene ancora ascoltato a distanza di decenni dai giovani e non.
Nonostante tutto, cosa ne pensi di “Forse le lucciole non si amano più”, a poco più di quarant’anni di distanza dalla sua uscita?
M.C.: Personalmente, quando mi capita di riascoltarlo, è sempre con un piacere nuovo perché la tecnica strumentale non è mai fine a se stessa. Ricordo volentieri che nessuno di noi voleva emergere sugli altri ma, al contrario, ogni strumento offriva lo spunto ad un altro strumento per raggiungere un senso armonico compiuto.
Una curiosità riguardo al periodo “post album”: mi parli del tour condiviso con Amanda Lear?
M.C.: Così mentre promozionavamo il nostro disco, anche nel tour con Amanda Lear che tu hai ricordato, ci accorgevamo che radio, dj e discoteche erano ormai orientati verso altre sonorità (disco soprattutto ma anche punk). Ricordo della differenza di partecipazione rispetto al periodo delle cover in cui i giovani occupavano, seduti per terra, le piste da ballo e in religioso silenzio ascoltavano brani non facili.
Proprio durante quel tour ebbi la sensazione, almeno un paio di volte, di suonare più per me stesso che per gli altri… Mi spiego meglio: nei minuti in cui io ero impegnato nel non semplice intro di piano di “A volte un istante di quiete”, con la coda dell’occhio percepivo distrazione o rumore e questo mi infastidiva.
La tua esperienza con la Locanda delle Fate termina poco dopo. Prima, però, c’è ancora tempo per un singolo “New York / Nove Lune” dalle sonorità decisamente lontane dal vostro Prog originario. Come mai decideste di “scendere a compromessi” con la “dimensione commerciale”?
M.C.: Di lì a poco, molte Progressive band (Genesis, Yes, Banco… per citarne alcune) sfornarono prodotti più orecchiabili e semplici e a me venne naturale comporre “New York” e il suo retro “Nove Lune” (per inciso, quest’ultima tutt’altro che facile dal punto di vista ritmico).
“New York” arrivò, se non sbaglio, all’undicesimo posto nella mitica Superclassifica Show di TV Sorrisi e Canzoni, però ci consegnava un futuro musicale che non ci apparteneva, dove la nostra tecnica strumentale e l’accuratezza nella ricerca sonora contavano ben poco. Veniva a mancare la passione e l’entusiasmo per quello che suonavano, per cui mollare tutto fu una scelta inevitabile.
I concerti, la band, il fervore socio-artistico del periodo: come ricordi quella decade magica? C’è qualche aneddoto che ti va di condividere?
M.C.: Certamente l’essere vissuto da ragazzo negli anni ‘70 è stato un privilegio unico. Non vorrei ripetermi, ma in quel decennio è avvenuta una rivoluzione musicale e del costume che vedi raramente nella storia dell’uomo. I Beatles diedero il via ad opere innovative e immortali, seguiti da Pink Floyd, King Crimson e via via tanti altri…
Ricordo, ad esempio, che all’età di 16 anni, durante una vacanza estiva nel campeggio di Albenga, ebbi l’opportunità di vedere i Genesis, ancora sconosciuti, in concerto nel loro primo tour italiano, nel palazzetto dello sport con non più di trecento ragazzi e seduto a pochi metri da un mito come Peter Gabriel. E se cresci con queste opportunità e questa educazione formativa che ti sta intorno, è molto difficile adattarsi ad una qualità così bassa come quella che ascoltiamo tutti i giorni.
Non credo ci siano parole per descrivere la differenza tra un rave party e un concerto di Carlos Santana visto con mio papà da ragazzo e quali influenze possono avere sul nostro animo le due diverse esperienze.
Mi sta venendo in mente un altro piacevole ricordo di quella “vacanza romana” e cioè, quando arrivammo nell’albergo di Piazzale Clodio per sistemare le nostre valigie, trovammo ad augurarci buona fortuna un amico musicista astigiano di nome Adelmo Musso, tastierista del cantante astigiano Piero Cotto. Superfluo dire che ci fece un gran piacere.
E poi ti ritrovi di fronte al “bivio della vita”: musica o studi. Scegli la seconda e intraprendi la carriera medica. Cosa ti ha spinto a mettere da parte i “tasti” (va detto, non definitivamente)?
M.C.: Ripresi con tenacia gli studi interrotti di medicina e faticai non poco per recuperare gli esami persi… Fare il medico ti cambia, nel senso che non è un lavoro come tanti… ma diventa tutta la tua vita… e gli hobbies, bene che vada, vengono confinati al fine settimana (…leggi musica…).
Il nuovo interesse per il Progressive Rock degli anni ’90 coinvolge anche la Locanda delle Fate e, nel 1993, la Mellow Records pubblica “Live”, la registrazione di un vostro concerto del 1977. Poi, negli anni successivi la band sente che è giunto il tempo di una reunion e nel 1999 pubblica “Homo Homini Lupus” (in cui compari in un solo brano). Come mai decidi di non partecipare alla rinascita (anzi, dovrei dire “alle rinascite”) del gruppo?
M.C.: Con i vecchi amici della Locanda ogni tanto ci si sentiva e si parlava della possibilità di riprendere a suonare insieme. Riuscimmo a ritrovarci in sala prove alla fine degli anni ‘90 ma il progetto musicale era già stato portato avanti molto da Ezio con un’impronta non Progressive. Così la poca disponibilità di tempo e una proposta musicale che sentivo poco vicina alle mie corde, mi fece decidere di abbandonare il progetto che uscì con il nome di “Homo Homini Lupus”.
Intorno al 2010 i Locandieri mi chiesero di partecipare ad un tour per suonare i vecchi brani di “Forse le lucciole non si amano più” ma, intanto, era ritornata in me la voglia di comporre brani nuovi e così decisi di dedicare il poco tempo per dare corpo a queste idee…
E poi incontri il rap. È il 2015 quando il rapper Dr. Dre inserisce il tuo arpeggio di piano tratto dal brano “Vendesi saggezza” nella sua “For The Love of Money”. L’album che la contiene, “Compton”, riceve una nomination quale Best Rap Album ai Grammy Award 2015 e, inoltre, diventa anche un film con tanto di candidatura agli Oscar. Ti va di raccontarmi come si è svolto il tutto? Cosa si prova a “ritrovarsi” catapultato in una dimensione come quella statunitense (e in un genere musicale molto distante dal Progressive Rock)?
M.C.: È proprio nel 2015 successe che ricevetti, un mattino presto, una telefonata dal direttore artistico della Universal Music italiana che mi informava, con grande entusiasmo e gratitudine (perché proprietari delle edizioni) della grande opportunità che avevo negli States e così fu organizzato un viaggio a Los Angeles dove conobbi i vertici della Universal, gli studi di registrazione di Dr. Dre, Hollywood e tutto quel mondo che neanche lontanamente pensavo di poter conoscere.
Nacquero dei bei propositi di collaborazione per altri brani rap e non solo e devo dire che, al ritorno in Italia, ero abbastanza su di giri e spedii a Los Angeles diverse idee…
Ma alla fine mi sono detto che avevo già un mio lavoro per vivere e il solito poco tempo lo avrei dedicato alla musica che mi piace realmente suonare… e non è certamente il rap!!
Il 2019 ti vede tornare “sulla piazza” con il tuo primo album solista “Endless Nights”, lavoro che contiene composizioni nate già negli anni ’80. Come mai questa “gestazione” così lunga prima di fare il “salto” e quando senti che è giunto il momento di pubblicare?
M.C.: Come accennato, intorno al 2010 tornò in me la voglia di comporre brani nuovi e dedicare il poco tempo nel dare corpo a queste idee… Così affrontai da solo il difficile lavoro, passando dalla parte compositiva agli arrangiamenti e poi le registrazioni, prima a Torino e poi a Londra agli studi Abbey Road.
ll caso ha voluto che incontrassi musicisti in sintonia con le mie idee, tipo il chitarrista Ermanno Brignolo, il tecnico del suono Simone lampedone e, non per ultimo, Gavin Harrison.
Tra i vari collaboratori, in “Endless Nights” troviamo, appunto, anche Gavin Harrison. Come nasce la cooperazione col batterista, tra gli altri, di Porcupine Tree e King Crimson?
M.C.: L’incontro con il grande batterista è stato veder realizzato un sogno. Mi dicevano che Gavin non era facilmente raggiungibile, non rispondeva alle mail e suonava solo la musica che gli piaceva.
Una sera, alla fine del lavoro, ero nel mio ambulatorio e decido, prima di spegnere il PC, di mandare una mail a un certo Gavin Harrison, ad un indirizzo che avevo trovato in rete, così come si prova a comprare un biglietto della lotteria (poche righe sulla mia storia e il progetto in corso). Con indicibile sorpresa, dopo qualche giorno apro con emozione la risposta che più o meno diceva così: Hi, sono Gavin Harrison, tu non hai scritto a me ma ad un mio omonimo che anche lui suona la batteria e vive in Inghilterra, ci conosciamo e lui mi ha girato la tua mail perché gli sembrava interessante…
E così, da un errore, è nata ed è proseguita una bellissima collaborazione ed amicizia…
In quel periodo Gavin era impegnato solo nelle prove del tour con i King Crimson, per cui aveva delle mezze giornate “libere” ed accettò di aiutarmi.
Finii le registrazioni a Londra nel novembre 2015 ma l’album fu commercializzato solo a fine 2019, dopo l’incontro con il produttore Matthias Scheller della AMS Record.
“Endless Nights”: notti senza fine. A cosa fai riferimento nel titolo dell’album?
M.C.: Il titolo “Endless Nights” nasce dal fatto che mi capita il fine settimana di rubare un po’ di tempo alla notte e, quindi, al sonno per raccogliere le idee musicali… Nei momenti in cui tutto intorno è silenzio.
Com’è stato accolto il tuo lavoro da critica e pubblico? Ed emergenza sanitaria a parte, avevi previsto anche un lato live promozionale?
M.C.: Era programmata una bella occasione musicale per presentare il disco a livello internazionale a Londra, alla Chelsea e Westminster Foundation, se non ricordo male il 25 febbraio del 2020, purtroppo sfuggita all’ultimo minuto per il brusco avvento in quei giorni della pandemia Covid: quindi volo e albergo annullati.
E proprio l’impegno indescrivibile nel mio lavoro per tutto il periodo della pandemia, non solo non mi ha dato la possibilità di presentare dal vivo “Endless Nights”, ma ha praticamente cancellato la musica dai miei pensieri per mesi e mesi…
Comunque il CD è stato ben accolto dalla critica e dalle radio che trasmettono Prog, soprattutto americane, giapponesi e inglesi… oltre ogni aspettativa della casa discografica. E questo mi ha dato l’input per tentare ancora un progetto musicale che sarà diverso da “Endless Nights” (che è, appunto, una raccolta di brani composti nell’arco di più decenni) e tenterò di raccontare, a modo mio, il declino e le contraddizioni del mondo in questo periodo della mia vita (sempre, però, con un senso di ottimismo per il futuro… che è proprio del mio carattere).
Cambiando discorso, il mondo del web e dei social è ormai parte integrante, forse preponderante, delle nostre vite, in generale, e della musica, in particolare. Quali sono i pro e i contro di questa “civiltà 2.0” secondo il tuo punto di vista per chi fa musica? E quali sono le difficoltà oggettive che rendono faticosa, al giorno d’oggi, la promozione della propria musica tali da ritrovarsi, ad esempio, quasi “obbligati” a ricorrere all’autoproduzione o ad una campagna di raccolta fondi online?
M.C.: L’avvento del digitale e la diminuzione dei costi per realizzare un CD sicuramente hanno reso più facile concretizzare le proprie idee, a scapito, però, della qualità sonora. Quindi io continuerò a cercare il giusto compromesso, anche perché, per fortuna, non ho venduto i vecchi synth analogici (a partire dal Minimoog).
Qual è la tua opinione sulla scena Progressiva Italiana attuale?
M.C.: Dai gruppi Prog Italiani degli ultimi anni che ho avuto modo di ascoltare non ho sentito proposte sonore che mi abbiano “catturato” l’attenzione e spesso ho notato una carenza di linee melodiche.
Esulando per un attimo dal mondo musicale di Michele Conta e parlando di gusti musicali, di background individuale (in fatto di ascolti), ti va di confessare il tuo “podio” di preferenze personali? E c’è un libro, uno scrittore o un artista (in qualsiasi campo) che ami e di cui consiglieresti di approfondirne la conoscenza a chi sta ora leggendo questa intervista?
M.C.: Mi chiedi se ascolto musica o leggo libri. Certamente sì, quando posso sono molto curioso per ogni aspetto dell’arte… Ascolto i generi più disparati, da Tchaikovsky e Debussy ai Tool e Steven Wilson sino ad Ennio Morricone, per citarne alcuni. Di recente ho riascoltato il bellissimo tema d’amore di “Blade Runner” di Vangelis e l’intensità dell’ultimo live dei The Cure.
Recentemente ho voluto rileggere poesie di Alda Merini e di Michele Mari e chissà se un giorno potrò andare in Ucraina in pace e tranquillità per poter ammirare gli ultimi murales di Banksy.
E tornando per un attimo ad “Endless Nights”: quanto ti è mancato suonare e registrare la tua musica in tutti questi anni? E, dunque, per chiudere: cosa prevede il futuro di Michele Conta?
M.C.: Hai notato che più volte ho detto della quotidiana mancanza di tempo per suonare tutta la musica che vorrei e, forse, questo desiderio spesso rimandato e mai completamente appagato è uno dei motivi per cui ho ancora voglia di suonare e penso che debba ancora trovare le note più belle.
Grazie di cuore Michele!
(Giugno, 2023 – Intervista tratta dal volume “Dialoghi Prog – Volume 4. Il Rock Progressivo Italiano del nuovo millennio raccontato dai protagonisti“)








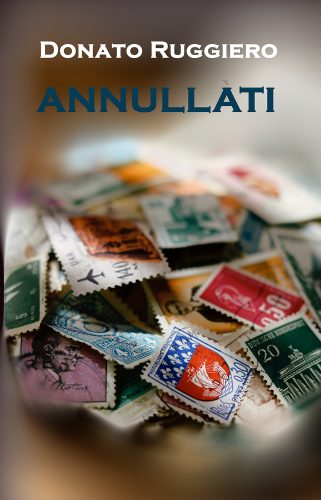
Lascia un commento